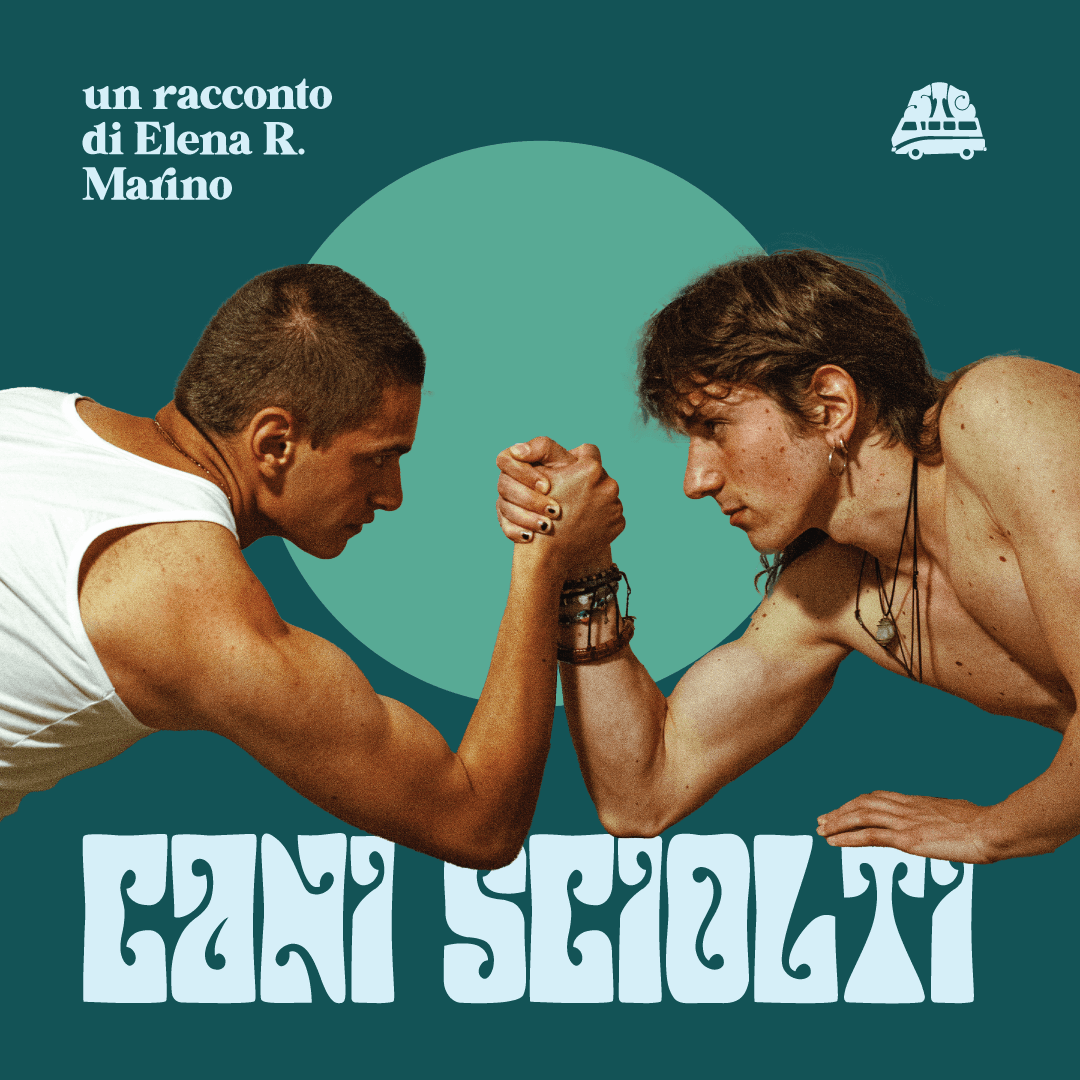un racconto di Attilio Di Sabato,
tutte le fotografie di Pietro Grossi.


Si massaggiò le tempie. Una. Due volte. Poi inforcò gli occhiali. La tastiera sotto al naso le pareva minuscola. S’era ristretta. Larga quanto una penna. Alzò lo sguardo e pure lo schermo s’era ridotto. Una fessura luminosa. Si voltò per chiamare la collega; che qualcuno le avesse fatto uno scherzo? Ma non ci riuscì, a girarsi. Le gambe erano incastrate tra la sedia e la scrivania.
«Oh!? E allora?»
«Che ti strilli?» le rispose uno alla sua destra.
«Che mi strillo? Che mi s-t-r-i-l…»
«Tutto bene, Ruth?» continuò la collega a sinistra.
Si sistemò di nuovo gli occhiali, schiacciati sulla faccia. La collega di sinistra sedeva su un minuscolo sgabello. Da un piede solo. Con ogni probabilità, ciò che rimaneva della poltrona da ufficio. Allungò il collo dall’altra parte, e pure il collega alla sua destra era messo allo stesso modo. Ancora, all’insù, il soffitto la pizzicava a un metro, uno e mezzo, dalla testa.

«Dai cazzo, non scherziamo».
Da sotto la scrivania fece leva coi piedi contro la parete. Recuperò una decina di passi all’indietro scorrendo sulle rotelle. Sbatté di schiena contro il muro. Si tirò su e diede una capocciata al soffitto. Ancora stordita, si accorse che le scarpe cominciavano a morderle i tendini sopra i talloni, i jeans stringevano i polpacci e le maniche della camicia giravano ai gomiti.
Batté le palpebre: non-c’era-più-spazio.
Iniziò a inveire contro i colleghi, ma nessuno capiva cosa volesse. E perché gridasse.
«Me ne vado, fanculo. Questi giochi… ma stiamo scherzando? Che roba… ma poi voi, come fate a non… fanculo. Fanculo!», sbraitò Ruth.

Si ritrovò in un corridoio angusto, in principio un open space. Fu costretta ad accovacciarsi. I colleghi allertarono il superiore. In fondo al canale striminzito, un tizio grasso, coi basettoni e la faccia da schiaffi, la stava aspettando. Con difficoltà Ruth avanzava verso l’uscita. E il superiore cominciò a parlarle sopra, mentre Ruth lo riempiva di parolacce. Diceva che non si può lavorare così. Si sono rimbecilliti tutti. Si lamentava dello scherzo. O forse era solo tanto stanca. L’uomo però non ascoltava. Le ripeteva di stare calma, di non urlare. Di tornarsene alla scrivania.
«Che diavolo fai Ruth!?» le disse il responsabile.
Ma Ruth continuò a sgranare bestemmie, una dopo l’altra. Superò l’uomo spalmandoglisi addosso. Il sudore, quello del superiore, le si ficcava nel naso. Acre. Sentì il suo fiato sulla guancia. Strizzò gli occhi Ruth. Tirando altre parolacce, altre bestemmie. Finalmente sbucò via da quell’inferno nanesco. Fuori l’ufficio le cose sembravano andare meglio.
Prese le scale. La sola idea che si rimpicciolisse pure l’ascensore la faceva andare ai matti. Cominciò allora a scendere di piano, gradino dopo gradino. Ma a ogni rampa quelli si accorciavano. Inciampò più volte. Con la punta del piede beccava lo scalino dove immaginava esserci il vuoto. E così il contrario. Prevedeva lo scalino e invece non c’era. Roba da pazzi, gridava, mentre i piani si assottigliavano man mano che proseguiva. L’ufficio era al decimo. Se lo ricordava che era al decimo. Ogni mattina, fino a quella mattina, le lampeggiava negli occhi il numerino “dieci” sopra la porta automatica dell’ascensore. Mica s’era impazzita. «Oh, non facciamo scherzi», urlò. Eppure ne scese tre, di piani.
“Me ne torno a casa”, pensò.

In strada era il delirio. Gli enormi grattacieli le parevano ora dei chiodi piantati in riga. Le auto schizzavano via sottili come frecce. Sui marciapiedi si camminava in fila indiana. A fatica riuscivi a metterci un piede avanti all’altro.
Adesso le scarpe grattavano le punte degli alluci, i jeans premevano alla coscia e le maniche della camicia coprivano a malapena le spalle.
Tutto ruotava. Stretto. Su delle fette spesse poco meno di uno spillo. E Ruth si zittì. Quasi che stupida e matta fosse stata prima, quando non vedeva la reale profondità delle cose.
Cominciò a vorticare sul posto. Assorbita dal movimento convettivo della città e dei suoi flussi di gente e di macchine. Di clacson. Di valigie. Di luci. Trapani, che forano assetati. L’acciaio. Arso. Bevuto dal sole, riflesso sul vetro. Mille odori. Un vuoto d’aria. Il pulviscolo soffoca al di sotto e al di sopra, dentro e fuori di sé. Centinaia di facce. Migliaia di uccelli in cielo. Tagliano rettilinei le nuvole oltre la polvere. Milioni di formiche dappertutto. Tra gli interstizi del cemento, lungo gli infissi delle finestre, al ripiegare dei pali, ficcate a piombo nelle fogne. Tutte le cose erano prosciugate, contratte in semplici segni, privi di materia, sovrapposti e svuotati di un senso proprio.
Ruth cominciò a correre. Prese una direzione e non la mollò più. La città le sembrò estendersi su una strada sola. Fissava dritto Ruth, con la paura che, se si fosse guardata intorno, non avrebbe trovato nulla. Perché tutto era collassato su una linea. Un unico maledetto sgraziato binario. Avanti o dietro. O la morte.
Sentì i muscoli frenare. E il metallo in bocca. Si fermò. Tirò un lungo sospiro, svuotando i polmoni dal cemento e riempiendoli con la terra. Dovette sbottonarsi il colletto per riprendere fiato. I vestiti. Non riusciva più a camminare: le dita dei piedi le facevano male, ripiegavano su sé stesse sotto la pressione delle scarpe, via via più corte. I jeans avevano superato di gran lunga la coscia risalendo fino all’inguine. Una leggera brezza le accarezzava l’ombelico dove prima c’era il cotone. Via tutto, pensò. Si svestì.
Di fronte, in lontananza, drizzava la cima di una montagna.
Forse là, pensò Ruth.
E riprese a correre.


editing di Alessandro Tesetti.