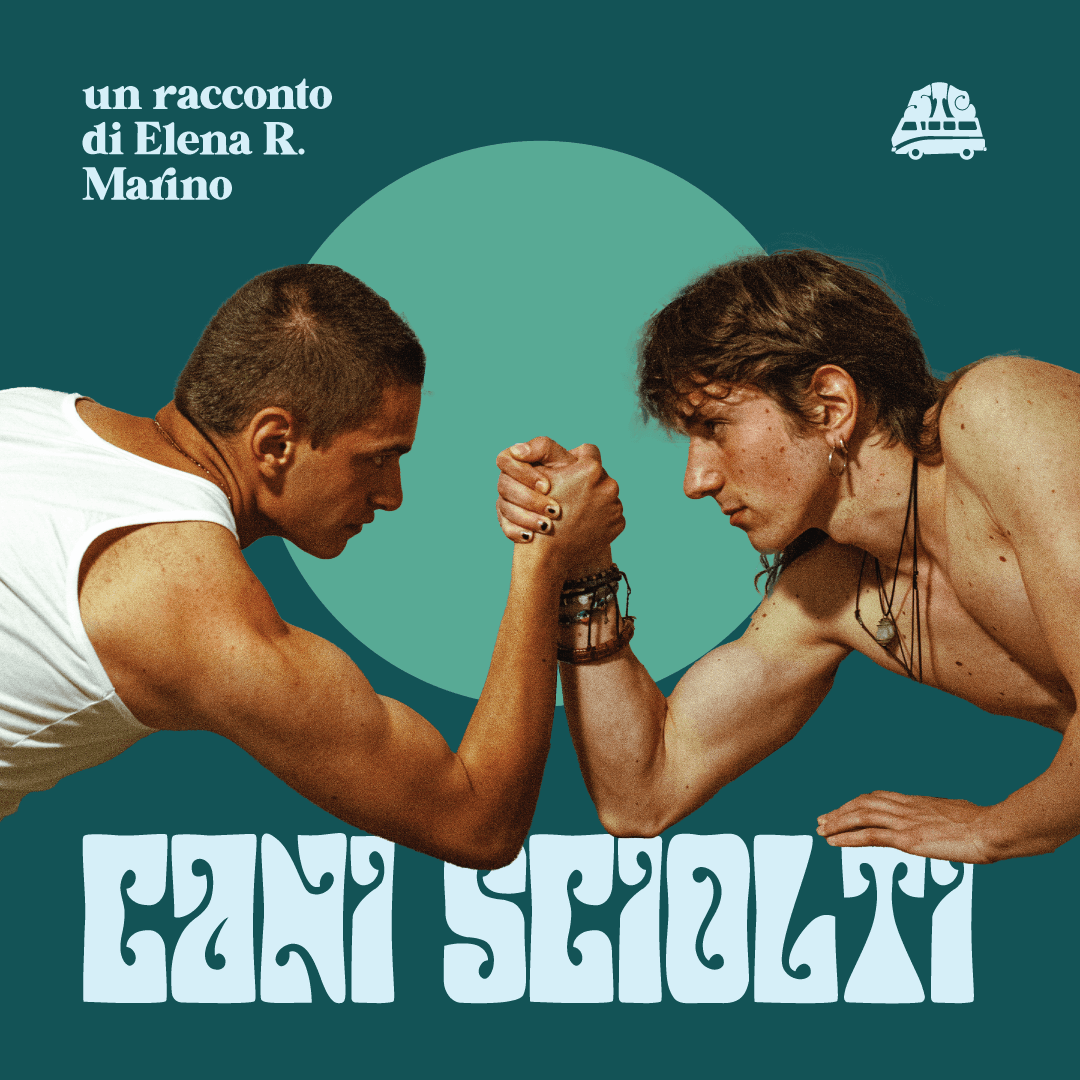un racconto di Simone Cappellaro,
tutte le fotografie di Paola Massarenti (“Foto Vere”).

Nel ’78 stavo in terza superiore al Galilei. Qualcuno quelli li chiamava anni di piombo, per me erano più che altro anni di transizione. Me ne accorsi un giorno che non era un giorno qualsiasi ma era un martedì. Il professore di fisica entrò in aula con la sua ventiquattrore nera e la giacca di cammello; il resto di lui era fatto di nebbia e leggi di Keplero, di grigiore resistente ai lavaggi. Solo la sua borsa e la sua giacca lo rendevano visibile, per il resto era mimetico, camaleonticamente tutt’uno con il muro dietro di sé.
Mi alzai e mi sedetti meccanicamente, unendomi al buongiorno di rito ma senza parlare, stropicciando appena le labbra. Era una routine collaudata, quasi insindacabile, quella delle ore di fisica. Il quaderno sarebbe rimasto aperto su una pagina bianca a righe sottili, il libro chiuso sul ripiano sotto al banco se non c’era compito in classe, altrimenti sempre sul ripiano sotto ma aperto. “Staedtler” e “Bic”, due scritte da leggere e rileggere nel corso di quelle due ore pesanti come un blocco da spingere su per un piano inclinato, con attrito.
Trigonometria, paesaggio d’autunno e spifferi d’inverno dalla finestra, termosifoni ancora ghiacciati.

Due file di banchi più avanti, Loretta si lasciava strangolare dai dolcevita fatti da sua madre all’uncinetto. Scriveva gli appunti in blu, di mano destra, mentre con la sinistra pizzicava l’angolino in basso della pagina del suo quaderno con la rilegatura ad anelli. Quando per pura memoria muscolare anche io segnavo gli appunti, li scrivevo in nero, e questo bastava a renderci incompatibili.
Il professore stava spiegando, percepivo un rumore di fondo mescolato a quello del traffico sotto alla finestra. Gli altri erano incastrati nelle strutture dei banchi, le gambe inchiodate e le braccia saldate alla superficie bianca, grattata di graffi di forbici e taglierini, ruvida e ferita. In quei segni segmentati c’erano la noia e i pensieri altrui, lasciati lì per i posteri.
Il mio vicino di banco si chiamava Marino, e non veniva più a scuola, credo non gli piacesse. D’altronde lui sapeva già lavorare, suo padre stava ai cantieri navali e gli aveva insegnato. Prima di non venire più aveva lasciato anche lui un ricordo della sua permanenza al Galilei. Un segno lungo, lineare, che incrociava altri solchi più brevi, spezzandoli; una riga tagliente, di lama di temperino. Così prima di Marino qualcuno aveva scritto “Figli delle Stelle”; dopo di Marino si leggeva “Figli di puttana”, con “puttana” scritto a capo. Erano tempi tosti, anni di transizione.

Mi ero convinto che avrei tirato avanti a non far nulla in classe fino alla maturità, così avrei avuto il tempo di scegliere cosa fare dopo, una volta fuori. Il pensiero del dopo mi pendolava nella testa, sbattendo sulla parte interna delle tempie una volta di qua e l’altra di là. “Chi ha tempo non aspetti tempo”, diceva mio padre, ma io del tempo non sapevo onestamente che farmene. L’attesa e la noia si mescolavano come uova e farina. Avevano il sapore della crema e il profumo di pozzanghere. C’era sempre qualcosa da aspettare, come la campanella o l’ora di religione, in cui si era autorizzati da programma a far niente.
Avrei voluto far niente anche dopo, in un maldefinito futuro, perché ero bravo a far niente. Era il mio, mi veniva naturale anche senza esercitarmi. Per questo colsi al volo l’occasione. Fu una giocata di talento naturale per il cazzeggio.
Il professore infilò una delle sue mani grigio nebbia dentro la tasca interna della giacca di cammello. Per una legge della fisica ancora non ben approfondita, solo in quel momento aveva l’attenzione dell’intera classe. Se ne rese nervosamente conto, e provò a recuperare il rigore scolastico e il filo del discorso e della sua autorità, anche se la sua faccia di nebbia rimase inespressiva. Era comodo tenere il pacchetto delle sigarette nella tasca della giacca, soprattutto perché poteva starci benissimo dentro senza dimenticarlo da qualche parte e tale dogma valeva anche per il professore, che sfilò una sigaretta dal pacchetto nella tasca e la prese in bocca. Noi restammo a guardarlo mentre l’accendeva, con il solo rumore del meccanismo dell’accendino a disturbare l’improvviso silenzio. Anche il traffico sotto la finestra pareva essersi fermato un minuto a guardare il professore tirare la prima boccata, e altre tinte di grigio e bianco sporco riempirono l’aria.
«Se a qualcuno dà fastidio il fumo, esca».

Il professore ricominciò a spiegare, perdendo in un istante l’attenzione di molti. Daniele della prima fila era titubante e asmatico, non sopportava il fumo e i brutti voti. Uscire voleva dire perdere buona parte della lezione di fisica. Era indeciso. Giorgio era impulsivo e bizzoso, amava scornarsi e collezionare punizioni. Lui non era indeciso, prese le sue cose e si alzò, dirigendosi verso la porta. Il professore non lo guardò nemmeno, si girò e, gesso alla mano, disegnò alla lavagna una carrucola, con tanto di pesi e forze agenti che si svelavano tra gli sbuffi di fumo che svanivano. Daniele tossì una volta, poi due; poi provò a trattenersi ma non ce la faceva. Rosso in faccia, uscì anche lui, ingobbito per l’agitazione e la mancanza d’aria fresca.
Io mi infilai nella sua scia, invisibile dietro di lui, senza attirare lo sguardo di nessuno: né del professore, né di Loretta.
Scesi in giardino. Mi sembrava che tutto il grigio che c’era in classe mi avesse seguito fuori, colorando le nuvole del cielo e i muri di cemento del Galilei. Daniele stava recuperando un colorito normale, Giorgio si era acceso una sigaretta, alla faccia del professore.

Io non facevo niente, ma lo facevo bene e soprattutto lo facevo fuori, all’aria aperta. C’era un vento frizzante quel giorno, che mi pizzicava sotto al giubbotto, lo ricordo bene. Rimasi a farmi sfiorare dalle bollicine fresche per un bel po’, intanto Daniele era rientrato in aula e Giorgio era sparito fuori dal cancello, a confondersi tra la gente.
Io mi diressi verso le rastrelliere, dove stavano agganciate le bici di tutti, vicino al parcheggio dei docenti. C’era una tettoia di plastica ondulata verde che fungeva da riparo contro la pioggia, ma più spesso serviva solo ai passeri per cagare e posarsi, aspettando la fine della ricreazione per sbeccare le briciole delle merende. Restai ad aspettare con i piccioni.
Dopo mi stufai anche di non far niente. Andai alla mia bici e la liberai dalla catena, poi la portai un po’ più in là, dove stava la bici di Loretta. Aveva il telaio verde scuro e le manopole bianche del manubrio. Agganciai le due biciclette assieme con la mia catena. E ripresi ad aspettare, seduto sulla rastrelliera tra una bici e l’altra. Respirai forte tutta l’aria grigia che i miei polmoni potessero contenere, ripresi fiato. Un soffio di vento stava sparpagliando un grumo di foglie secche marroni in tutto il piazzale, colorandolo di autunno. Era il cambio di stagione, tempi di transizione.
E io avevo fatto qualcosa.


editing di Giulio Frangioni.